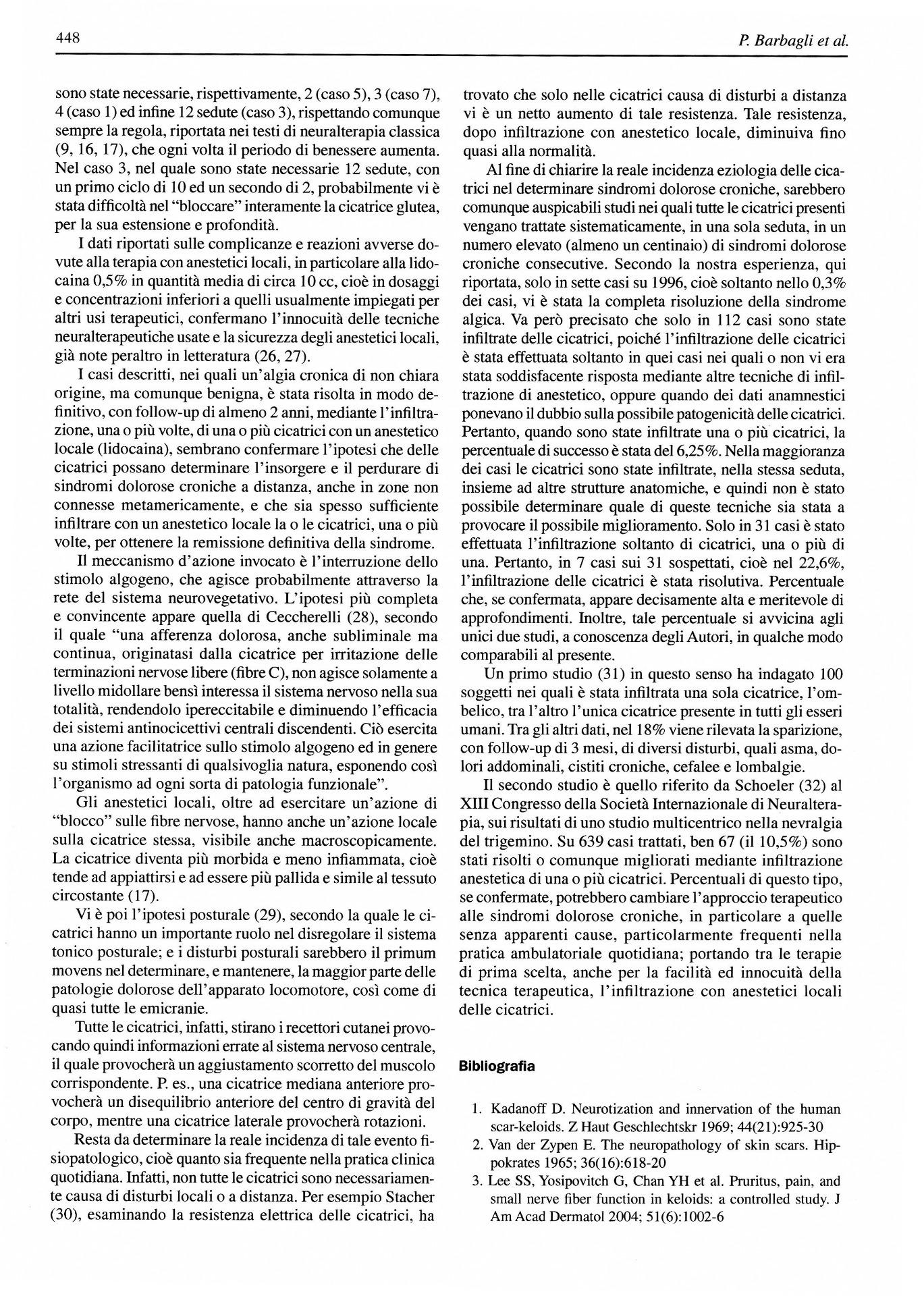— Pubblicazioni sulle cicatrici —
ATTI MEDCAM 2013 - Lazise, 25-27 ottobre 2013IV CONGRESSO INTERNAZIONALE DELLE MEDICINE NON CONVENZIONALI E SCIENZE OLISTICHE
RUOLO DELLE CICATRICI NELLA GENESI DI SINDROMI DOLOROSE CRONICHE
Paolo Barbagli - Renza Bollettin
Ambulatorio di Medicina Antalgica, Riva del Garda (TN)
A.I.R.A.S. (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Aggiornamento Scientifico), Padova
Introduzione
E' da tempo noto e documentato che cicatrici, in particolare ipertrofiche e cheloidee, possano frequentemente causare dolore locale (1, 2). Meno frequente, ma comunque documentata, la possibilità che una cicatrice possa causare dolore a distanza intrappolando nervi o radici nervose, quali p. es. lo sciatico (3). Scarsamente considerata invece, nella letteratura scientifica più accreditata, forse perché più difficile da giustificare su basi neurofisiologiche, la possibilità che una o più cicatrici possano causare dolore a distanza anche in zone non correlate metamericamente.
Gli Autori cercheranno qui di indagare sull'ipotesi che a causare sindromi dolorose croniche siano talvolta una o più cicatrici, sia in zone limitrofe alle cicatrici stesse che in zone apparentemente non correlate neurologicamente.
Come è nata l'ipotesi delle cicatrici causa di dolore a distanza
L'importanza delle cicatrici nel determinare malattie croniche a distanza, comprese le sindromi dolorose, fu per la prima volta sospettata nei primi anni del Novecento da due medici tedeschi, i fratelli Huneke. Sulla base di un caso clinico capitato fortuitamente introdussero in medicina il concetto di "campo disturbante" (Störfeld) (4), cioè una localizzazione somatica, spesso una cicatrice, altre volte organi quali i denti o le tonsille, in grado di provocare altri disturbi cronici a distanza. Il cosiddetto "fenomeno del secondo" o "fenomeno di Huneke" avverrebbe quando, infiltrando tale zona con un anestetico locale, p. es. la procaina, si ha la sparizione completa ed immediata, e per almeno diverse ore, di un disturbo anche apparentemente non collegato con la zona trattata. Per comprendere meglio questi concetti, che rimangono tuttora sconosciuti alla maggior parte dei medici perché non sono stati mai insegnati nell'ambito dei normali corsi di laurea, sembra opportuno riportare in breve il caso clinico che ha dato origine a queste teorie.
I fratelli Walter e Ferdinand Huneke, medici di medicina generale a Düsseldorf, dal 1925 usavano largamente la procaina come terapia per svariate patologie, soprattutto dolorose (5). Nel 1940 giunse da loro una paziente con una grave sindrome dolorosa alla spalla sinistra, che venne trattata senza successo mediante ponfi, iniezioni intraarticolari e blocchi nervosi con procaina; cioè mediante la tecnica neuralterapeutica denominata segmentale, cioè basata sulla stimolazione del "segmento2 o "metamero" connesso. La paziente, delusa, ritornò a casa, la lontana Breslavia, ma fu costretta a ritornare dagli Huneke per la comparsa di una dolorosissima infiammazione ad una grossa cicatrice alla gamba destra, dovuta ad una antica osteomielite. Gli Huneke, convinti del potere antiinfiammatorio della procaina, decisero di infiltrare la cicatrice infiammata con Impletol, una soluzione anestetica a base di procaina al 2 % e piccole quantità di caffeina. Con grande stupore dei medici e della paziente, immediatamente scomparve il dolore alla spalla malata, che finalmente poteva essere mossa liberamente. Questo fenomeno venne denominato dagli Huneke "fenomeno del secondo" (6, 7), proprio per la estrema velocità che lo caratterizza. Tale fenomeno fu denominato in seguito anche "fenomeno di Huneke", e venne elaborata la teoria del "campo perturbante" o "di disturbo", che rappresenta un'evoluzione delle teorie "focali" allora in voga.
Denominarono inoltre la loro terapia "neuralterapia" (8, 9), poiché l'immediatezza delle loro guarigioni faceva pensare ad un intervento del sistema nervoso periferico. Sicuramente anche altri prima di loro avevano osservato tali fenomeni, e tra questi il famoso chirurgo francese Leriche, che osservò e descrisse già nel 1936 la scomparsa di dolori a distanza dopo infiltrazione di una cicatrice (10).
Ma solo i fratelli Huneke svilupparono delle teorie compiute da tali osservazioni, creando anche una scuola che ebbe largo seguito, specialmente in Germania e tra i medici di Medicina Generale. Numerose pubblicazioni, purtroppo quasi esclusivamente su riviste in tedesco di difficile accesso, confermerebbero le intuizioni degli Huneke (11, 12).
Secondo gli Huneke si può parlare di vero "fenomeno del secondo" solo in presenza delle seguenti condizioni (6, 7): 1) i disturbi dovuti al "campo disturbante" devono scomparire al 100 % immediatamente, nei limiti delle possibilità anatomiche; 2) la completa assenza dei sintomi deve mantenersi per almeno 8 ore nel caso di iniezione dei denti, e di almeno 20 ore in tutti gli altri casi; 3) ad ogni nuova infiltrazione di anestetico la durata del fenomeno deve allungarsi ogni volta di più.
La letteratura
In una recente nostra review sul possibile ruolo eziologico delle cicatrici nel generare dolore a distanza (13) vengono analizzati 157 casi nei quali la relazione tra cicatrici e sindromi dolorose croniche a distanza sembra particolarmente stretta, casi nei quali l'infiltrazione della o delle cicatrici con un anestetico locale (v. figura 1), ma anche mediante la semplice infissione di aghi, l'elettroagopuntura (v. figura 2) o il trattamento con altre metodiche non invasive quali p. es. il laser, ha provocato la scomparsa o il netto miglioramento di patologie dolorose a distanza.
Figura 1: tecnica di infiltrazione delle cicatrici (da Dosch M.: Bildatlas zur Technick der Neuraltherapie mit Lokalanästhetika. Heidelberg, Haug Verlag)
Figura 2: tecnica di elettrostimolazione delle cicatrici mediante elettroagopuntura (14)
Nella stessa review vengono inoltre riportati diversi studi che suggeriscono in modo indiretto l'ipotesi di un ruolo patogeno delle cicatrici.
Come lo studio di Hoppe (15), secondo il quale il 23 % degli intervistati che riferiscono disturbi attribuiti all'influenza del tempo soffrono di dolori ad una o più cicatrici. Pertanto, circa un quarto dei cosiddetti meteoropatici sembra avere dolore nelle cicatrici. E' del resto opinione comune che molte cicatrici diventino dolenti ai cambiamenti del tempo.
L'alta incidenza di processi dolorosi in presenza di cicatrici è confermata anche da uno studio di Dauber (16) sui sopravvissuti tra i grandi ustionati. Il 52 % tra questi, dopo 11 anni in media dopo l'ustione, ha risposto di soffrire di dolore, pur senza precisare in quali zone corporee. Molti di questi (il 49 %) hanno dolore di intensità tale da disturbare le loro attività quotidiane. La stragrande maggioranza di questi (il 79 %) attribuiva la causa del loro dolore all'ustione, e alla cicatrice derivata da questa.
Del resto, l'incidenza di dolore cronico, negli ustionati, sembra correlato con l'ampiezza dell'area ustionata, come riferito da Malenfant (17), che riporta una percentuale dell'86 % di dolori a 1 anno dall'ustione.
Numerosi inoltre sono gli studi che dimostrano una elevata percentuale di dolore postoperatorio a distanza, anche se prevalentemente in distretti corporei vicini alla cicatrice operatoria, ed in assenza di processi organici rilevabili nei distretti dolorosi.
P. es. Eisenberg (18), negli operati per bypass coronarico, riferisce un 56 % con dolore toracico e, in un gruppo di 80 pazienti che sono stati visitati, il 58,7 % con dolore alla cicatrice sternale (con allodinia), il 66,2 % con dolore al torace sinistro (con ipoestesia, allodinia e aumento della soglia termica) e l'11,2 % con dolore al torace di destra.
Husted (19) riporta dal 29 al 47 % di dolori al collo, alla spalla e alla cicatrice dopo intervento chirurgico di mastectomia.
Con procedure chirurgiche meno invasive, come la toracoscopia (20), la percentuale dei pazienti con dolore alla cicatrice e in altre zone toraciche diminuisce nettamente (rispettivamente 5 % e 20 % dopo 6 mesi), ma tende ugualmente a persistere a lungo (2 anni dopo ancora il 4 % con dolore toracico lieve o moderato).
Dopo chirurgia toracica, diversi studi riportano un'alta incidenza di PPTP (persistent post-thoracotomy pain), che varia dal 26 al 67 %: tutti tranne uno (21) parlano di percentuali superiori al 50 % (22-26). Il più interessante al nostro scopo è sicuramente quello di Perttunen (26). Perttunen riporta una mappa di localizzazione dei dolori cronici post-toracotomia. Nel 90 % dei casi, come era logico attendersi, il dolore era localizzato nella cicatrice, ma nel 63 % era localizzato invece in zona scapolare, nel 36 % in zona pettorale, nel 40 % nel braccio, nel 13 % alla spalla, nel 5 % in zona sternale, e nel 12 % in altri distretti corporei. In pratica, in un gran numero di casi si è sviluppato, oltre ad un dolore alla cicatrice, uno o più dolori in distretti corporei anche molto distanti.
Gavrin, all'interno del fondamentale testo sul dolore di Bonica (27), riconosce l'esistenza delle sindromi post-toracotomia e post-mastectomia, ma le attribuisce non tanto alla cicatrice quanto al trauma dei nervi intercostali, con conseguente formazione di neuroma. La localizzazione del dolore, spesso diversa e lontana dalla zona innervata dai nervi intercostali (26), sembra però smentire questa ipotesi ed aprire il campo, almeno in una parte dei casi, ad una genesi mediata dalla cicatrice, più che dal trauma diretto del nervo.
Johansen, sempre nel Bonica (28), esprime analoghe considerazioni sul dolore addominale post-chirurgico o posttraumatico, e attribuisce il dolore a piccoli neuromi formatisi nelle cicatrici. Il trattamento raccomandato è comunque l'infiltrazione delle cicatrici con blocchi ripetuti di anestetici locali, che "portano ad una risoluzione del dolore di sempre maggiore durata e possono essere terapeutiche": affermazioni simili a quelle dei neuralterapeuti germanici.
Un altro esempio di cicatrice coinvolta nella ricomparsa di dolore lombare dopo un intervento per ernia discale è la cosiddetta "cicatrice epidurale", "una densa cicatrice fibrosa che comprime la dura e le radici nervose" e difficilmente trattabile (29).
In un ulteriore nostro lavoro (30) si riferiscono le esperienze degli Autori sull'infiltrazione con anestetico locale, quasi sempre lidocaina, di cicatrici in casi di dolore cronico. In una casistica di 2145 soggetti (dei quali 1996 con sindromi dolorose) trattati mediante neuralterapia secondo Huneke, cioè usando un anestetico locale (quasi sempre la lidocaina) a scopo terapeutico, in 7 casi (su 112 casi trattati con questa metodica), che vengono descritti in dettaglio, l'infiltrazione di una o più cicatrici ha risolto, con follow up di almeno 2 anni, sindromi dolorose a distanza che in precedenza erano risultate refrattarie a tutte le terapie effettuate, oltre ad essere di difficile inquadramento nosologico.
In questa casistica, in 3 casi (casi 2, 4 e 6) è stata sufficiente, per la risoluzione della patologia algica, una singola infiltrazione di una o più cicatrici, mentre negli altri 4 casi sono state necessarie, rispettivamente, 2 (caso 5), 3 (caso 7), 4 (caso 1) ed infine 12 sedute (caso 3), rispettando comunque sempre la regola, riportata nei testi di neuralterapia classica (9, 17, 18), che ogni volta il periodo di benessere aumenta. Nel caso 3, nel quale sono state necessarie 12 sedute, con un primo ciclo di 10 ed un secondo di 2, probabilmente vi è stata difficoltà nel "bloccare" interamente la cicatrice glutea, per la sua estensione e profondità.
Possibili meccanismi eziopatogenetici
Il meccanismo che provocherebbe l'instaurarsi di una sindrome dolorosa cronica a partire da una o più cicatrici rimanga sconosciuto, sono state invocate alcune ipotesi. Quella a nostro parere più convincente appare quella di Ceccherelli (31), secondo il quale "una afferenza dolorosa, anche subliminale ma continua, originatasi dalla cicatrice per irritazione delle terminazioni nervose libere (fibre C), non agisce solamente a livello midollare bensì interessa il sistema nervoso nella sua totalità, rendendolo ipereccitabile e diminuendo l'efficacia dei sistemi antinocicettivi centrali discendenti. Ciò esercita una azione facilitatrice sullo stimolo algogeno ed in genere su stimoli stressanti di qualsivoglia natura, esponendo così l'organismo ad ogni sorta di patologia funzionale".
Vi sarebbe inoltre un'ipotesi posturale (32), secondo la quale le cicatrici hanno un importante ruolo nel disregolare il sistema tonico posturale; e i disturbi posturali sarebbero il primum movens nel determinare, e mantenere, la maggior parte delle patologie dolorose dell'apparato locomotore, così come di quasi tutte le emicranie.
Tutte le cicatrici, infatti, stirano i recettori cutanei provocando quindi informazioni errate al sistema nervoso centrale, il quale provocherà un aggiustamento scorretto del muscolo corrispondente. P. es., una cicatrice mediana anteriore provocherà un disequilibrio anteriore del centro di gravità del corpo, mentre una cicatrice laterale provocherà rotazioni.
Incidenza
Resta da determinare la reale incidenza della presenza di cicatrici patogene, cioè quanto sia frequente questa evenienza nella pratica clinica quotidiana. Infatti, non tutte le cicatrici sono necessariamente causa di disturbi locali o a distanza. Per esempio Stacher (33), esaminando la resistenza elettrica delle cicatrici, ha trovato che solo nelle cicatrici causa di disturbi a distanza vi è un netto aumento di tale resistenza. Tale resistenza, dopo infiltrazione con anestetico locale, diminuiva fino quasi alla normalità.
Al fine di chiarire la reale incidenza eziologia delle cicatrici nel determinare sindromi dolorose croniche, sarebbero comunque auspicabili studi nei quali tutte le cicatrici presenti vengano trattate sistematicamente, in una sola seduta, in un numero elevato (almeno un centinaio) di sindromi dolorose croniche consecutive. Secondo la nostra esperienza (30), su 2145 soggetti (dei quali 1996 con sindromi dolorose) trattati con anestetici locali (neuralterapia secondo Huneke), solo in 112 casi sono state infiltrate delle cicatrici, poiché l'infiltrazione delle cicatrici è stata effettuata soltanto quando o non vi era stata soddisfacente risposta mediante altre tecniche di infiltrazione di anestetico, oppure quando dei dati anamnestici ponevano il sospetto sulla possibile patogenicità delle cicatrici. Pertanto, quando sono state infiltrate una o più cicatrici, la percentuale di successo è stata del 6,25 %. Nella maggioranza dei casi le cicatrici sono state infiltrate, nella stessa seduta, insieme ad altre strutture anatomiche, e quindi non è stato possibile determinare quale di queste tecniche sia stata a provocare il possibile miglioramento. Solo in 31 casi è stata effettuata l'infiltrazione soltanto di cicatrici, una o più di una, con risoluzione della sindrome algica in 7 casi sui 31 sospettati, cioè nel 22,6 %. Percentuale che, se confermata, appare decisamente alta e meritevole di approfondimenti. Inoltre, tale percentuale si avvicina agli unici due studi, a conoscenza degli Autori, in qualche modo comparabili al nostro.
Un primo studio (34) in questo senso ha indagato 100 soggetti nei quali è stata infiltrata una sola cicatrice, l'ombelico, tra l'altro l'unica cicatrice presente in tutti gli esseri umani. Tra gli altri dati, nel 18 % viene rilevata la sparizione, con follow-up di 3 mesi, di diversi disturbi, quali asma, dolori addominali, cistiti croniche, cefalee e lombalgie.
Il secondo studio è quello riferito da Schöler (35) al XIII Congresso della Società Internazionale di Neuralterapia, sui risultati di uno studio multicentrico nella nevralgia del trigemino. Su 639 casi trattati, ben 67 (il 10,5 %) sono stati risolti o comunque migliorati mediante infiltrazione anestetica di una o più cicatrici. Percentuali di questo tipo, se confermate, potrebbero cambiare l'approccio terapeutico alle sindromi dolorose croniche, in particolare a quelle senza apparenti cause, particolarmente frequenti nella pratica ambulatoriale quotidiana; portando tra le terapie di prima scelta, anche per la facilità ed innocuità della tecnica terapeutica, l'infiltrazione con anestetici locali delle cicatrici.
Conclusioni
Da questo excursus in letteratura sono stati trovati 157 casi di pazienti nei quali sembra molto probabile un nesso causale tra cicatrice e dolore a distanza, nonché diversi studi che suggeriscono in modo indiretto un qualche ruolo patogeno delle cicatrici nella genesi di dolori cronici a distanza.
Il fatto che questi casi siano spesso descritti in pubblicazioni con scarsa risonanza o in modo aneddotico, sparsi qua e là in pubblicazioni di altra natura; oppure in articoli, come quello di Lewit su Pain (36), che se ne occupano in modo marginale o con semplici accenni, ne spiega la scarsa conoscenza nella comunità scientifica.
Inoltre, i casi qui riportati probabilmente rappresentano solo una parte di quelli nascosti negli anfratti della sterminata produzione scientifica mondiale. Casi che, insieme a tutte le considerazioni ulteriori fin qui brevemente illustrate, benchè non diano una risposta conclusiva al quesito: "le cicatrici possono essere causa di dolore cronico a distanza ?", inducono a ritenere tale ipotesi come possibile, se non addirittura come probabile.
Sono state inoltre qui brevemente esaminate alcune ipotesi eziologiche che potrebbero spiegare il ruolo delle cicatrici nel determinare l'insorgenza di sindromi dolorose croniche, ed è stato per la prima volta esaminato il problema della possibile incidenza di tale fenomeno sul totale delle cicatrici, che varierebbe, a seconda degli studi riportati, dal 10 al 22,5 %.
Se confermati, i dati sopra riportati potrebbero avere una grande rilevanza nel cambiare l'attuale strategia terapeutica delle sindrome algiche croniche, e il trattamento (mediante diverse possibili opzioni terapeutiche, quali p. es. l'infiltrazione con anestetico locale o con soluzione fisiologica, la semplice infissione di aghi, il laser o il semplice massaggio) delle cicatrici, vista anche la semplicità e l'innocuità della tecniche prospettate, potrebbe diventare un'opzione terapeutica di prima scelta.
Bibliografia
1. Defalque RJ. Painful trigger points in surgical scars. Anesth Analg 1982; 61: 518-20
2. Johansen KH, Patchen Dellinger E, Loeser JD. Cicatrici dolorose. In: Loeser JD (edr). Bonica's trattamento del dolore. Edizione italiana sulla 3. Americana di "Bonica's management of pain". Antonio Delfino Editore, Roma, 2003, p. 1346
3. Oldershaw JB, Salem A, Storrs BB et al. Sciatic nerve entrapment in the upper thigh caused by an injury sustained during World War II at the battle of Anzio. Case report. J Neurosurg 2004; 100 (3 Suppl Spine): 295-
4. Dosch P. Die Injektion in die Narben. In: Lehrbuch der Neuraltherapie nach Huneke (Therapie mit Lokalanästhetika) (ed. X). Haug Verlag, Heidelberg, 1981, pp. 353-354
5. Huneke F e W. Unbekannte Fernwirkungen der Lokalanästhesie. Med Welt 1928: 27
6. Huneke F. Das Sekundenphänomen. Neuralmedizin 1953; 1: 62-75
7. Huneke F. Das Sekundenphänomen in der Neuraltherapie. 6. Edizione, Heidelberg: Haug Verlag; 1989
8. Dosch P. Lehrbuch der Neuraltherapie nach Huneke (Therapie mit Lokalanästhetika). 10. Edizione, Heidelberg: Haug Verlag: 1981
9. Barop H. Manuale e Atlante di Terapia Neurale secondo Huneke. Milano; Edi. Ermes: 2003
10. Leriche A. Literaturstelle über die Stellatumanästhesie bei Hirnembolie, bei Gefäßspasmen, nach Hirnoperationen und bei Hemiplegien. Rev Chir 1936; 55: 755
11. Helling R. Störfelddiagnostick. Störfeld und Regulationsfahigkeit. Akupunktur 2003; 31 (1): 24-33
12. Mastalier O. Das Störfeld. Dtsch Akupunkt 1997; 40 (2): 29-36
13. Barbagli P, Ceccherelli F. Possible etiopathogenic role of scars in chronic non malignant pain. Cases and case records. Minerva Med 2005; 96, 3 (suppl. 2): 15-23
14. Gagliardi G. L'elettroagopuntura ad alta frequenza come alternativa all'infiltrazione della cicatrice in paziente con ipersensibilità agli anestetici locale. Case report. https://blog.airas.it/?p=509
15. Hoppe P, von Mackensen S, Nowak D, Piel E. Prävalenz von Wetterfuhligkeit in Deutschland. Dtsch Med Wochenschr 2002; 127 (1-2): 15-20
16. Dauber A, Osgood PF, Breslau AJ, Vernon HL, Carr DB. Chronic persistent pain after severe burns: a survey of 358 burn survivors. Pain Medicine 2002; 3 (1): 6-12
17. Malenfant A, Forget R, Papillon J, Amsel R, Frigon J-Y, Chonière M. Prevalence and characteristics of chronic sensory problems in burn patients. Pain 1996; 67: 493-500
18. Eisenberg E, Pultorak Y, Pud D, Bar-El Y. Prevalence and characteristics of post coronary artery bypass graft surgery pain (PCP). Pain 2001; 92 (1-2): 11-7
19. Husted H, Lauridsen M-C, Torsleff K, Erichsen C. Senfolger hos patientez opereret for bryst kraeft. En sporges Kemaundersogelse i Sonderjyllands Amt. (Late symptoms among patients surgically treated for breast cancer. A questionnaire in the county of Southern Jutland). Ugeskr Laeger 1995; 157 (49): 6868-72
20. Stammberger U, Steinacher C, Hillinger S, Schmid R-A, Kinsbergen T, Weder W. Early and long-term complaints following video-assisted thoracoscopic surgery: evaluation in 173 patients. Eur J Cardiothorac Surg 2000; 18 (1): 7-11
21. Kanner RM, Martini N, Foley KM. Nature and incidence of post-thoracotomy pain. Proceedings of the American Society of Clinical Oncology 1982; 1: 152
22. Kalso E, Perttunen K, Kaasinen S. Pain after thoracic surgery. Acta Anaesthesiol Scand 1992; 36: 96-100
23. Matsunaga M, Dan K, Manable FY, Hara F. Residual pain of 90 thoracotomy patients with malignancy and non-malignancy. Pain 1990; suppl 5: S148
24. Dajczman E, Gordon A, Kreisman H, Wolkove N. Long-term postthoracotomy pain. Chest 1991; 99: 270-4
25. Katz J, Jackson M, Kavanagh BP, Sandler AN. Acute pain after thoracic surgery predicts long-term post-thoracotomy pain. Clin J Pain 1996; 12: 50-5
26.Perttunen K, Tasmuth T, Kalso E. Chronic pain after thoracic surgery: a follow-up study. Acta Anaesthesiol Scand 1999; 43: 563-67
27. Gavrin JR. Neuropatia intercostale e periferica. In: Loeser JD (a cura di). Bonica's trattamento del dolore. Edizione italiana sulla 3. Americana di "Bonica's management of pain", Roma: Antonio Delfino Editore; 2003, p. 1218
28. Johansen KH, Patchen Dellinger E, Loeser JD. Cicatrici dolorose. Loeser JD (a cura di). Bonica's trattamento del dolore. Edizione italiana sulla 3. Americana di "Bonica's management of pain", Roma: Antonio Delfino Editore; 2003, p. 1346
29. Spangfort E. Formazione di cicatrici epidurali. Wall PD, Melzack R. Il dolore. Edizione italiana di "Textbook of pain", Roma: Verduci Editore; 1988, p. 679
30. Barbagli P, Bollettin R. Nostre esperienze sul trattamento del dolore cronico benigno mediante infiltrazione di cicatrici con anestetico locale. Clin Ter 2009; 160 (6): 445-9
31. Ceccherelli F. Centralità della cicatrice nella fisiopatologia di fenomeni patologici segmentali ed a distanza. In: Dispense del quarto anno del Corso di Riflessoterapia. A.I.R.A.S. (Associazione Italiana per la Ricerca e l'Aggiornamento Scientifico), Padova, 1999, pp. 224-8
32. Bricot B. Le cicatrici patologiche. In: La riprogrammazione posturale globale. Statipro, Marsiglia, 1998, pp. 186-9
33. Stacher A. Über das Huneke- (Sekunden-) Phänomen und seine Objektivierung. In: Voss HF: Deshalb Neuraltherapie. ML-Verlag, Ülzen, 1968
34. Weinschenk S. Campo interferente en ombligo. (The umbilicus interference field). Terapianeural.com, www.terapianeural.com/Mexic_2000/Stefan.htm (12.12.2004)
35. Schöler H. Trigeminus-Neuralgie. In: Dosch P. Lehrbuch der Neuraltherapie nach Huneke (Therapie mit Lokalanästhetika) (ed. X). Haug Verlag, Heidelberg, 1981, pp. 258-9
36. Lewit K. The needle effect in the relief of myofascial pain. Pain 1979; 6: 83-90